7.- SADISMO, MASOCHISMO, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ UNA RILETTURA DEL TRACCIATO FREUDIANO
Daniela De Robertis
Daniela De Robertis Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
Freud e le versioni metapsicologiche
Il tema del sadismo e del masochismo è affrontato da Freud in varie opere,che corrispondono a vari periodi della scrittura metapsicologica. Le letture che egli ne restituisce risultano diverse e talvolta addirittura opposte e rovesciate,come avrò modo di circostanziare in seguito.
Una costante tuttavia rimane come leit-motiv durante tutto l’arco della teorizzazione freudiana: il sadismo risulta legato all’attività e il masochismo alla passività.
L’affresco di più ampio respiro su questo tema si ritrova nel 1915 in Pulsioni e loro destini (Freud, 1915).
Tuttavia già dieci anni prima Freud ne aveva fatto menzione: infatti nei Tre saggi sulla teoria sessuale (Freud, 1905) il sadismo e il masochismo vengono rubricati nell’ampia categoria delle pulsioni di crudeltà , rispettivamente nella loro forma attiva e passiva. Esse sono accreditate nell’infanzia all’interno della concezione freudiana del bambino perverso e polimorfo.
Soltanto più tardi nella IV conferenza sulla Psicoanalisi, Freud indagando sempre in riferimento al bambino il “piacere di procurare dolore”, definito sadismo, e il suo corrispettivo risvolto passivo, definito masochismo, precisa che queste due pulsioni “compaiono in coppie antitetiche”o coppie di opposti, in forma rispettivamente attiva e passiva(Freud, 1909, p.162).
L’idea di coppia antitetica rappresenta quell’anticipazione che troverà poi il suo pieno sviluppo nel grande saggio del ’15.
Di nuovo nel 1910, ma questa volta in riferimento non all’infanzia , ma all’età adulta e alle nevrosi ossessive, Freud (1910a, p. 201) ribadisce la connotazione di attività della pulsione sadica e la connotazione di passività della pulsione masochistica. Questa equazione, che circoscrive l’attributo dell’attività al sadismo e quello della passività al masochismo, rimarrà un referente ben saldo nell’approccio freudiano, indipendentemente dalle aggiunte e revisioni che subirà il concetto di attività e passività. Intendo riferirmi a quel versante del pensiero freudiano che ascrive l’attività all’elemento maschile e la passività all’elemento femminile ( Freud, 1924; 1931)¹ .
E giungiamo così a Pulsioni e loro destini, la più ampia trattazione che Freud (1915) abbia riservato a questo argomento. Il testo, particolarmente complesso e non privo di oscurità, poggia su alcuni assiomi principali, che vale la pena riepilogare.
1- Sadismo e masochismo sono due pulsioni sessuali, le quali, in quanto riferite all’infanzia,
rientrano nelle pulsioni parziali, cioè in quel “fascio” di pulsioni non ancora unificate sotto il primato della genitalità.
2- Al medesimo tempo queste due pulsioni sono considerate anche due destini pulsionali. In
questo secondo punto emerge già una contraddizione, poiché a ben vedere, nel proseguo del testo, soltanto il masochismo risulterà detenere il ruolo di destino pulsionale del sadismo e non anche viceversa, come ci si aspetterebbe dalla premessa .
3- Il destino pulsionale è la difesa in cui incorre la pulsione. A questo punto ecco emergere anche l’esplicitazione di senso dell’affascinante titolo del Saggio.
4- La difesa chiamata in causa per la pulsione sadica è la trasformazione nel contrario,
e più precisamente il cambiamento da attività in passività. Infatti il sadismo, pulsione attiva,
viene trasformato ad opera della difesa interna ad esso nel suo corrispettivo passivo, cioè il
masochismo. In questo spaccato teorico, quindi il sadismo, considerato da Freud una
pulsione, sembra contenere in sé ed “autogestire” la propria difesa; ne deriva che il
masochismo è una pulsione che esprime la difesa effettuata. In sintesi
si tratta di una configurazione del modello teorico e del concetto di conflitto in cui la difesa è
assorbita e contenuta nel concetto di pulsione.
5-Questo tipo di difesa, cioè la trasformazione nel contrario nell’accezione di cambiamento da attività in passività, è una difesa precoce da distinguere da difese più tardive e mature, quali ad esempio la rimozione (Freud, 1915b, p. 37 ).
Il testo freudiano è estremamente sollecitante, ma anche alquanto contraddittorio e criptico.
Vediamo prima le aporie concettuali.
E’ cosa nota in Freud che tutta la logica della metapsicologia è d’impronta dualistica, costantemente mirata a tener ben distinto e contrapposto l’asse pulsionale dall’asse difensivo, cioè a tener ben distanziato il polo rimosso da quello rimovente². L’operazione è resa necessaria dalla logica del conflitto, perché, qualora i due assi fossero inclusi nello stesso concetto, vacillerebbe tutta l’impalcatura metapsicologica del conflitto e di conseguenza tutta la spiegazione della psicopatologia³. Dunque il problema non sarebbe certo di poco conto se pulsione e difesa fossero assorbiti in un’ unica entità concettuale, ma è esattamente ciò che si verifica in Pulsioni e loro destini . Proprio in base all’impianto metapsicologico, leggendo questa opera, sorge spontaneo chiedersi come sia possibile che all’interno della pulsione stessa sia insita la difesa, a tal punto da far parte del suo “destino”. La domanda si legittima anche sulla base di un’altra aporia presente nel testo che sembra disattendere e oscurare la sostanziale differenza tra il concetto di pulsione e quello di difesa. Infatti la pulsione si connota come elemento dinamico per la sua intrinseca tendenza alla scarica, spiegata e regolamentata dallo statuto omeostatico. La difesa, al contrario, in qualità di elemento che impedisce la scarica, svolge una funzione opposta, che lavora contro l’equilibrio omeostatico. Ecco anche la seconda ragione per la quale in tutta la metapsicologia i due concetti debbono mantenere spazi, funzioni e caratteristiche ben diverse.
In sintesi, alla luce del conflitto e della diversa natura tra pulsione e difesa, concepiti quali poli contrapposti, il discorso intrapreso da Freud nel ’15, che invece ingloba la difesa nella pulsione, risulta collocarsi in maniera “eccentrica” o comunque non conforme al contesto metapsicologico, introducendo nel testo punti di frizione e di scarto.
Ma il testo, dicevamo, contiene anche delle oscurità, nella misura in cui elude alcuni rilevanti quesiti. Si tratta di non detti che finiscono col gravare sulla comprensibilità e la coerenza del discorso. Di fatto Freud non sembra spiegare in che senso sadismo e masochismo, in qualità di pulsioni, incorrano nelle difese: non risulta agevole , stando alla lettura del testo, rinvenire in che senso si tratti di difese e soprattutto da che cosa ci si difenda . Insomma resta imprecisato quale sia la natura del rimosso e quale sia il motivo e la funzione svolta dal rimovente. Tanto meno vengono argomentate le ragioni per cui la trasformazione della pulsione sadica in quella masochistica venga considerata una difesa “precoce”.
In questa sede Freud elude questi quesiti, ma , a distanza di qualche anno in Al di là del principio di piacere, l’argomentazione intrapresa da Freud permette di trovare una risposta a questi interrogativi, consentendo di chiarire il ruolo della difesa nel rapporto tra sadismo e masochismo.
Freud infatti, avendo indagato in precedenza già da svariati anni il sadismo e il masochismo, deve aver avuto modo di verificare che la libido aveva una portata spiegativa limitata, poiché non era in grado di dar conto di una bella fetta delle vicissitudini psichiche, quelle appunto legate all’odio e alla distruttività (De Robertis, 2004), di cui sadismo e masochismo sono manifestazioni. Ritenere la libido l’unico referente spiegativo, e perseguire questa forma di riduzionismo sessuale può considerarsi, in ultima analisi il vero motivo per cui Freud non era riuscito a venire a capo nel fornire una spiegazione del rapporto tra sadismo e masochismo.
Di fatto nelle intenzioni di Freud la nuova teoria degli istinti del 1920 doveva assolvere la funzione di ridimensionare l’esclusività del referente sessuale, nella misura in cui l’istinto di morte nasce con il mandato di saturare questo spazio rimasto ineluso dalla teoria.L’istinto di morte viene quindi codificato nell’accezione di distruttività originaria, alla cui origine ora Freud può ricondurre l’aggressività della condotta umana e le conseguenti manifestazioni sintomatiche da essa derivate.
Sarà proprio in Al di là del principio di piacere (Freud, 1920), e in questo caso in un contesto di profonda revisione della scacchiera teorica, che Freud potrà esplicitare gli interrogativi lasciati inevasi nel ’15: l’oggetto della difesa è l’istinto di morte .
Più in concreto, introducendo il bipolarismo pulsionale dell’istinto di morte e dell’istinto di vita, Freud finalmente può procedere a spiegare il sadismo e a concepirlo come originaria espressione dell’innatismo dell’istinto di morte nella sua valenza distruttiva. A questo punto anche il masochismo viene incamerato nei limiti di sagoma dell’istinto di morte e più precisamente come una forma derivata dall’introiezione della pulsione sadica; una difesa appunto per stornare dall’esterno la propria distruttività, rivolgendola sulla propria persona. In sintesi il sadismo, fin dalle origini rivolto all’esterno, è considerato una forma di attività e il masochismo,in seconda battuta rivolto all’interno, la sua corrispettiva forma passiva. Ecco che i pezzi cominciano a ricomporsi: la pulsione in questione è il sadismo, la difesa contro di essa è svolta dal masochismo, il meccanismo difensivo impiegato è l’introiezione e il risultato di tutta l’operazione è il contenimento dei temibili effetti della distruttività’ grazie ad una manovra di internalizzazione. A ben vedere soltanto ora con questa versione del ‘20 la formula difensiva è spiegata; il sadismo rappresenta la manifestazione “originaria” dell’istinto di morte , attivamente agita nello spazio esterno e il masochismo ne è la risposta difensiva e secondaria rivolta all’interno. Ma è opportuno precisare che nel ‘20 nell’approccio freudiano la trasformazione nel contrario riguarda solo la trasformazione dalla forma attiva in quella passiva e non viceversa . E’una formula che, è utile precisare,viaggia soltanto in una direzione: dall’attività alla passività. In altre parole Freud contempla esclusivamente il sadismo che, in taluni casi, può diventare masochismo qualora sia sottoposto all’effetto della difesa. In altri momenti invece, come Nel problema economico del masochismo (Freud,1924, pp.9-10), Freud rovescia la formula, partendo da un masochismo originario che in seconda battuta può venire “estroflesso” all’esterno in forma di sadismo. Ma in altri luoghi viene sostenuta anche una terza versione a metà tra le due, puntando su una distruttività originaria di cui una parte viene sviata all’esterno (sadismo) e un’altra si conserva all’interno (masochismo).
Vorrei puntualizzare un aspetto cruciale di questa posizione freudiana: sia che Freud proponga un sadismo originario, sia che propenda per un masochismo originario sia che , forse proprio non sapendo che pesci prendere , prospetti anche una formula mista, sta di fatto che sadismo e masochismo, agganciati al carro dell’istinto di morte, appaiono innati, non si configurano come una possibile risposta, un tempo secondario,un “dopo”, un après coup,costruito in base agli eventi esperenziali nello spazio e nel tempo della vita. Piuttosto la spiegazione è delegata da Freud al terreno costituzionale, ad un innatismo che, per propria natura, è prescisso dal fattore esperenziale: un elemento che è così fin dalle origini e che non lascia più spazio a nulla da spiegare. Questo punto rappresenta un grosso limite epistemico della teoria freudiana: una teoria psicologica che, incernierata sull’istinto di morte a spiegazione dello psichico, delega il compito esplicativo ad un istinto costituzionalmente dato, finisce per rinnegare il mandato della spiegazione psicologica e , incrociando le braccia, rinuncia al proprio dominio epistemico, con l’effetto che l’innatismo è divenuto un dogma e la psiche è messa a tacere.
Tuttavia in parallelo a questa lettura, è possibile individuare nel pensiero freudiano un’altra e diversa pista, a mio avviso molto più convincente, perché più psicologicamente articolata.
Mi riferisco alla posizione che Freud assume nel 1931 e che qui sintetizzo:
un’ ”impressione ricevuta passivamente desta una tendenza ad una reazione attiva”. Quando il soggetto tenta di fare la stessa cosa che in precedenza è stata fatta a lui, è inconsciamente motivato dal fine di integrare un’esperienza passiva in un’azione attiva (Freud, 1931,p.73).
In questa lettura Freud rovescia la formula precedentemente esposta in Pulsioni e loro destini e in Al di là del principio di piacere: non sostiene più che dall’attività si passi alla passività ,ma è dalla passività che si passa all’attività. Questa a mio avviso è una spiegazione di gran lunga più promettente per due ragioni.
Innanzitutto aggancia il sadismo, inteso quale reazione attiva, alle vicende storiche del soggetto e lo legge come una risposta costruita in base alle esperienze. Questa spiegazione risulta più psichicamente articolata di quanto fosse la precedente che, agganciata all’istinto di morte, cioè ad un elemento a priori e biologistico, risulta carente nel fornire una spiegazione psichica.
In secondo luogo, la spiegazione, entrando nel merito dell’esperienza, permette di fare i conti con il vissuto emotivo ad essa legato.
Sadismo e masochismo come risposte esperenziali
Sicuramente tanto il sadismo, quanto il masochismo, sono condotte alla cui origine è individuabile un vissuto legato alla rabbia. In quest’ambito gli studiosi delle emozioni sollecitano a distinguere risposte funzionali, come l’aggressività,chiamata dagli psicologi delle emozioni avversatività, e risposte disfunzionali che vanno dalla rabbia, alla vendicatività, alla rivendicazione, alla violenza, alla distruttività. L’aggressività fa parte delle emozioni primarie, è un comportamento reattivo e funzionale, rubricabile nel repertorio emozionale innato che in quanto tale svolge un’ importante funzione adattiva. Si tratta di una reattività guidata da una difesa “utile”, che scatta di fronte ad un’esperienza emotiva in atto o ad un ricordo, elicitando una risposta emozionale che il soggetto è in grado di padroneggiare (de Zuleta, 1993).
Ben altro mette in campo la rabbia, la vendicatività e la distruttività, che sono da considerarsi espressioni di una reattività disfunzionale, perché agita all’interno di un assetto intrapsichico di un Sé scompaginato e frammentato, che è impossibilitato a gestire adattivamente il risvolto emozionale che ha suscitato o suscita l’esperienza.
Questa differenziazione ha portato alcuni autori a distinguere un’“aggressività semplice” da un’ “aggressività trasformata in vissuti aggressivi, rimossi e convertiti” (Durbin e Bowlby, 1939).
Alla luce di queste considerazioni vorrei tornare sul significato di difesa “precoce”. Come ho in precedenza citato, Freud (1915a; 1915b), analizzando le vicissitudini della vita psichica, individua nella trasformazione dalla polarità attiva a quella passiva l’azione di una difesa precoce, primitiva in senso cronologico ed evolutivo.
Sembra difficile sostenere oggi questo punto di vista rispetto alla diversa concezione dell’infanzia che i risultati dell’Infant Research e dell’Infant Observation restituiscono. Infatti, come attribuire alla prima o primissima infanzia comportamenti sadici e masochistici che spesso sotto forma di rituali esprimono modalità difensive, facenti parte del Sé e delle sue modalità relazionali strutturalmente consolidate? Riflessione questa che induce a postdatarne la comparsa verso un’età più avanzata. Come possiamo quindi considerare il significato della difesa precoce presente in Freud?
Sarei portata ad individuare la difesa non nella trasformazione da attività a passività, bensì da passività ad attività, secondo la lettura alternativa che lo stesso Freud, come ho accennato, prospetta nel 1931. Vorrei precisare però il tratto distintivo di questo tipo di attività: essa, essendo originata da una difesa che fa perno sull’asse della vendicatività, si presenta come una forma di pseudo-attività o “falsa” attività, al rimorchio della logica del trauma e delle risposte reattive, compensatorie e non elaborabili di esso. Allora abbiamo a che fare con una difesa che non è “precoce”, ma primitiva, nel senso di elementare e semplice: una difesa che appartiene ad un Sé disarticolato e frammentato, incapace di gestire il dolore psichico derivato da esperienze traumatiche e abusanti. Un Sé che reagisce al dolore solo attraverso il rovesciamento semplicistico,“meccanico” e reattivo nel contrario, secondo una formula fondata sulla negazione, così riassumibile: non sono io che ricevo dolore è l’altro. Dal subire al far subire,dal percepirsi soggetto impotente di sofferenza , all’infliggere attivamente sofferenza all’altro,dall’esposizione passiva al trauma alla riproposizione attiva di esso, il tutto giocato su inversioni di rotte e di senso:Io-altro, dentro-fuori, supinamente-attivamente.
E’ questo il significato della strategia inconscia che sottolineano anche autori come Bowlby (1973) e Searles (1956), quando inseriscono nella categoria della vendicatività forme di rabbia dis funzionali. Si tratta di una reazione limite, una specie di ultima risorsa, che scatta quando il soggetto “sente” che non c’è nessun’altra reazione possibile. E’ a questo proposito che Bowlby conia l’espressione “collera della disperazione”, che si può concretizzare in una spinta a distruggere a causa del vissuto di essere stati distrutti (Bowlby,1973,cap. 17).
Anche Kohut, legando la vendicatività ai bisogni dell’area narcisistica, afferma che il bisogno di vendicarsi, di raddrizzare un torto, di annullare un danno con qualsiasi mezzo, supportato da un’ “implacabile” coazione a ripetere sono le caratteristiche della rabbia narcisistica in tutti i suoi risvolti. Il desiderio di volgere un’esperienza passiva in una attiva è una causa che può spiegare la l’immediatezza reattiva con cui il soggetto risponde usando un “rimedio” semplice, strutturalmente divenuto quasi automatico: infliggere attivamente all’altro quelle ferite narcisistiche che un tempo ha subito e patito,una ritorsione vista come effetto di un “risarcimento irrisarcibile” (Kohut,1972).
Il sadismo può essere letto alla luce di una vendicatività diretta dal fine di pareggiare i conti, di “rifarsi”, guidata da una specie di legge del taglione che comanda che quel che è fatto sia reso.
Questi autori del postfreudismo, diversamente dal punto di vista freudiano e kleiniano, non si muovono in un ambito biologistico e costituzionale, ma fanno propria una spiegazione esperienziale, legata al vissuto emotivo. Bowlby sottolinea il carattere secondario, e non primario, del comportamento rabbioso/vendicativo, un comportamento non ascrivibile all’istinto, ma alla reattività della risposta.
Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Searles (1956), nel sostenere che la vendicatività è strettamente funzionale alla rimozione del dolore.
Anche Horney (1948) ha approfondito la funzionalità psichica della dinamica della vendetta, che individua nella necessità di riparare la ferita narcisistica, nel ripristino dell’orgoglio offeso e nel riscatto dell’originaria situazione d’impotenza. Per quest’autrice, come anche per Socarides (1966) le condotte vendicative diventano la passione che guida tutta la vita e a cui tutto è subordinato, persino l’interesse verso se stessi. Tutti gli intenti, tutte le energie sono allora dedicate all’unico scopo di ottenere un trionfo vendicativo.
Spesso i comportamenti sadici, non solo in ambito sessuale, ma anche morale, sono agiti da soggetti che vivono in funzione della vendetta, che diventa una spinta motivazionale tale da tradursi nell’unico scopo della loro vita (Ibid.).Non bisogna dimenticare -soprattutto ai fini del trattamento clinico di questa sintomatologia- che la vendetta svolge una funzione compensatoria e “trofica” ,al punto di assumere una funzionalità strutturale, nel senso di procurare un nutrimento ad un Io debole, svuotato e fragile all’interno dell’economia psichica.
Concludendo, ho voluto proporre una lettura del sadismo in cui la vendicatività, sotto forma di pseudo-attività, gioca il ruolo di una difesa multifunzionale, centrata su due funzionalità di base:
l’aggiramento del dolore e il tentativo -per quanto disfunzionale e maladattivo- di ripristinare la compromessa integrità del Sé.
Per il masochismo, invece, la situazione mi appare differente, in quanto mi sembra una risposta più conservativa e meno reattiva rispetto al sadismo. Intendo centrare l’attenzione sulla considerazione che nelle sintomatologie masochistiche il soggetto si ripropone nell’esperienza storica di passività originaria, secondo la quale si vede inconsciamente come colui che subisce e continua a subire. In questi casi la coazione a ripetere sembrerebbe essere legata alla rigida aderenza all’immagine di Sé, e più specificamente all’immagine di un Sé abusato. Nel riperpetuare la condizione e l’esperienza d’abuso e di violenza, il soggetto si identifica e quindi si riconferma in quell’immagine che rappresenta la sua inconscia identità di base.
Sintetizzando ho proposto di considerare le manifestazioni sadiche come una risposta attraverso la quale l’originaria passività, legata al vissuto del subire il “danno”, per scopi difensivi è trasformata in pseudo-attività.
Diversamente le manifestazioni masochistiche esprimono l’originario vissuto di passività, riproposto rigidamente dal soggetto a conservazione della propria identità inconscia di “abusato”.
NOTE
¹ L’attribuzione freudiana del parametro attività all’elemento maschile e del parametro passività all’elemento femminile è un chiaro esempio di quanto gli stereotipi culturali di una data epoca si convertano in teorizzazioni che vanno a costituire le tessere del modello (Drescher, 2008, p. 312).
² E’ nota l’impostazione dicotomica che Freud imprime alla vita psichica(Freud, 1920,p.238), incardinata sul dualismo pulsione-difesa. Di fatto in tutto lo sviluppo e le revisioni della metapsicologia è motivo dominante in Freud differenziare la natura del rimovente come contrapposto al rimosso, soprattutto quando, da una generica denominazione di difesa-censura, presente fino al ‘900, si passa ad una definizione più dettagliata di essa . Da quel momento in poi ritroveremo infatti via via concettualizzazioni sempre più articolate di ciò che si contrappone al pulsionale, rintracciabile dapprima nel concetto di Potenze psichiche (Freud, 1905), poi di Pulsioni dell’Io (Freud, 1910b), poi ancora di Ideale dell’Io (Freud,1914), in seguito di Istinto di morte (Freud,1920) e infine di Super Io (Freud, 1922).
³ La necessità di distinguere , anche dal punto di vista topico, l’istanza rimovente dall’istanza rimossa è da considerarsi uno dei principali motori all’origine della revisione strutturale . Sarà ne L’Io e l’Es infatti che Freud (1922), decretando ufficialmente la natura inconscia della difesa , ma non potendo posizionare la difesa nell’Es , sede pulsionale per eccellenza, pena la disintegrazione dell’idea di conflitto, situa la difesa nelle parti inconsce dell’Io. Con tale operazione Freud si assicura il duplice vantaggio di garantire la natura inconscia delle manovre difensive e di salvaguardare il conflitto , ripartendo topicamente le pulsioni nell’Es e le difese ( o più precisamente la “gestione” di esse) nell’Io.
BIBLIOGRAFIA
Bowlby J. (1973) Attaccamento e perdita . La separazione dalla madre vol. II, trad.it., Bollati Boringhieri , Torino,1978.
de Zelueta F.(1993) From Pain to Violence Whurr Publishers, London.
Drescher J. (2008) Dall’omosessualità e dalla bisessualità all’intersessualità: ripensando alle categorie di genere Psicoterapia e Scienze Umane XLII, 3, pp.301-318.
Durbin E.F.M. Bowlby J. (1939) Personal Aggressiveness and War Routledge and Kegan Paul, London.
Freud S.(1905) Tre Saggi sulla teoria sessuale OSF, vol.IV, Boringhieri, Torino,1972.
Freud S.(1909) Cinque Conferenze sulla Psicoanalisi OSF, vol.VI, Boringhieri, Torino,1974.
Freud S. (1910a) Prospettive future della terapia psicoanalitica OSF, vol.VI, Boringhieri, Torino,1974.
Freud S. (1910b) I Disturbi visivi psicogeni nell’interpretazione psicoanalitica OSF, vol.VI, Boringhieri, Torino,1974.
Freud S. (1914) Introduzione al narcisismo OSF, vol.VII, Boringhieri, Torino,1976.
Freud S. (1015a) Pulsioni e loro destini OSF, vol.VIII, Boringhieri, Torino,1976.
Freud S. (1915b) La Rimozione OSF, vol. VIII, Boringhieri, Torino,1976.
Freud S . (1920) Al di là del principio di piacere OSF, vol.IX, Boringhieri, Torino,1977.
Freud S . (1922) L’Io e l’Es OSF, vol.IX Boringhieri, Torino,1977.
Freud S. (1924) Il problema economico dl masochismo OSF,vol. X, Boringhieri, Torino, 1978.
Freud S. (1931) Sessualità femminile OSF, vol.XI, Bollati Boringhieri, Torino,1979.
Horney K. (1948) The Value of Vindictiveness J. of the Amer. Psychoan. Ass., 8, pp 3-12.
Kohut H. (1972) Pensieri sul narcisismo e sulla rabbia narcisistica in La ricerca del Sé trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1978.
Searles H.F. (1956) The Psychodynamics of Vengefulness in Collected Papers on Schizophrenia and Related Subjects Hogarth Press, London, 1965 .
Socarides C.W. (1966) On Vengeance: the Desire to “get eve” in C.W. Socarides(ed.) 1977. The World of Emotions. Clinical Study of Affect and their Expressions Intern. Univ.Press,
SOMMARIO
Rispetto al sadismo e al masochismo,all’attività e alla passività e alla difesa,l’A. nella prima parte propone una rassegna e una rilettura delle versioni spesso diverse e opposte che propone il tracciato metapsicologico.
Nella seconda parte l’A., avvalendosi del pensiero di alcuni autori del postfreudismo, quali Bowlby, Kohut, Searles, etc.e alla luce dei teorici delle emozioni, distingue risposte funzionali (aggressività),da risposte disfunzionali (rabbia, violenza, vendetta , distruttività) . In questa prospettiva il sadismo è una risposta attiva,sebbene disfunzionale , che mira a trasformare l’esperienza di aver subito e vissuto passivamente l’abuso, nell’esperienza di infliggerlo all’altro, allo scopo di aggirare il dolore e ripristinare la compromessa integrità del Sé.
Diversamente le manifestazioni masochistiche esprimono l’originario vissuto di passività, riproposto rigidamente dal soggetto a conservazione della propria identità inconscia di “abusato”.
PAROLE-CHIAVE:sadismo,masochismo,passività, attività,rabbia, distruttività, metapsicologia
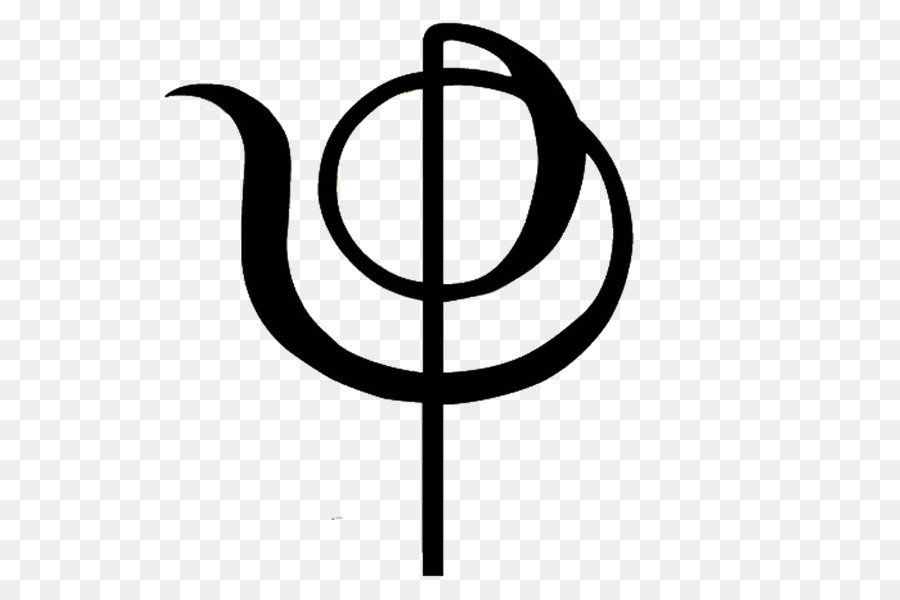
¿Por qué lastimamos al personal de salud? Guadalupe Sánchez Semsoac. Julio 2020 La emergencia causada por la enfermedad Covid-19 es un período atípico que altera el estado emocional produciendo angustia por el miedo a morir que reprimimos en la vida cotidiana. Vivimos un malestar social, una condición de trauma social porque no podemos darle un lugar en nuestra propia mente. Se incorpora la experiencia en fragmentos que, inconscientemente se rechazan y que suelen ser dirigidos hacia el exterior, hacia quienes encarnan más vulnerabilidad como el personal de salud. Queremos comprender por qué en México se dan ataques al personal médico y de enfermería a pesar de los llamados a no discriminar, en contraste con otros países en donde se les aclamó espontáneamente como héroes. El psicoanálisis ofrece algunas aproximaciones. La agresión en contra del personal de salud, es una reacción exacerbada de ansiedad insertada en una paradoja para algunos irresoluble: atacar a quien nos puede salvar. Se trata de un estado interno de desorganización mental que carece de la habilidad para discernir cuál es la fuente de peligro o cuál de salvación, porque en estos contextos ambas pueden ser encarnadas en la misma persona como ocurre con las figuras cuidadoras de los infantes que son al mismo tiempo figuras amenazantes. Este paso al acto es un ataque concreto impulsivo e irracional, desesperado por auto preservarse y que trata de eliminar al que cree es agente del mal, percibido como el objeto malo, de odio, culpable de su sufrimiento, disociando lo bueno de lo malo y sin la posibilidad de integrar esos aspectos. El fenómeno va mucho más allá de una discriminación consciente y es más complejo por las motivaciones inconscientes derivadas por una historia socioafectiva previa y un carácter determinado por la situación social económica y cultural en que se creció. En México traemos una historia social de mucha violencia, además una historia de muchos años atrás de maltrato por parte del personal de salud a las y los derechohabientes debido a la falta de recursos en el sistema público de salud. La pandemia re-traumatiza, ¿podrán cuidar de mí para no morir? Observamos respuestas narcisistas de dos tipos. Por un lado, una respuesta narcisista benigna y adaptativa a las distintas etapas de la pandemia, que, aunque niega temporalmente lo que está pasando: “a mí no me va a pasar”, “yo no me voy a morir” que reta inicialmente, pero que evoluciona y enfrenta eventualmente las señales de la realidad. La segunda es una respuesta narcisista de tipo maligna no adaptativa, que es delirante, persecutoria, y que, según Freud, yace en los mecanismos más inconscientes y primitivos de todos los seres humanos que implica omnipotencia del pensamiento, con vivencias de daño, castigo y violencia que destruye. Consideramos que las personas con una historia biofi lica y amorosa serán solidarios, cuidadosos de los demás y podrán tolerar con mayor fuerza esta adversidad. En cambio, cuando vemos estas respuestas violentas encontramos que la desesperanza es alta. Cuando hay desesperanza para poder cambiar la realidad, se es más propenso a lastimar a nuestros seres significativos. Esta aproximación nos permite concientizar que en situaciones extremas nadie está exento de sentir desesperación frustración e impotencia y pasar inconscientemente a la agresión. También es una invitación a que es posible conscientemente tomar acciones balanceadas para “aplanar la curva de la discriminación”. Psicoanalista del Seminario de Sociopsicoanálisis A.C. Agradezco a mis colegas: Dr. Juan José Bustamante, Dra. Patricia González y Dra. Angelica Rodarte su colaboración para esta reflexión. lupssan@hotmail.com

Las guardianas de la salud Tiempos de covid19 en México Patricia González Duarte y Guadalupe Sánchez Seminario de Sociopsicoanálisis AC (Semsoac) Miembros Fundadoras. Julio 2020 Vivir bajo una condición de emergencia sanitaria, una contingencia que nos confronta todos los días con la muerte, se vuelve una condición de trauma para los ciudadanos y para el personal de salud en especial. Las enfermeras, los enfermeros, así como el maestro y las maestras que gozaron en el pasado de una posición de respeto en la sociedad, se fue perdiendo con la modernidad, incluso se infravaloró. ¿Cómo y cuándo se perdió el vínculo con las enfermeras? En medio de esta infravaloración llegaron a la actual crisis sanitaria. Un mes después de que comenzó la pandemia, en Abril 2020, se supo por los medios de comunicación de agresiones al personal de salud, muestras nada solidarias; se les agredió física, social y psicológicamente, se les discriminó, amenaza y hostigó. Los daños iban desde un improperio hasta arrojarles bebidas calientes o cloro, o bien golpearles en un caso, en cuya defensa la enfermera se fracturó dos dedos. Se amenazó en una ocasión con prender fuego a un hospital si se reconvertía a Covid o se les negó la entrada a lugares públicos como supermercados, al transporte público e incluso que entraran a su domicilio. Los agresores fueron hombres o mujeres desconocidos, extraños en la calle, familiares de pacientes hospitalizados o bien de entre el mismo personal de salud e conflicto por tanto estrés laboral. Se trata de un fenómeno que sorprendió al mundo. Proviene de la ignorancia dicen los comentaristas y de los fuertes prejuicios por discriminación. En realidad psicológicamente proviene de un psiquismo con un complejo funcionamiento narcisista que demuestra graves errores de juicio y falta de objetividad, por el miedo extremo a l a enfermedad y a la muerte imposible de regular. La falta de control de impulsividad les lleva a cruzar los límites de lo socialmente aceptado y permitido. La angustia extrema inculpa a las enfermeras de diseminar el virus “a mí no me va a contagiar” antes los lastimo, lo cual causa socialmente indignación. Las guardianes de la salud fueron así estigmatizadas y violentadas. Al mismo tiempo en contraste, han surgido por parte tanto del gobierno, como de empresas privadas, así como de la ciudadanía estrategias para combatir la estigmatización, y frenar la agresión, sensibilizando sobre su difícil situación, valorando su labor, proponiendo en redes sociales y en los medios de comunicación, reconocimiento, a través de aplausos, serenatas y menciones, se pide agradecimiento (en algunas colonias como la de Valle se les celebra como en España) solidaridad y protección, poniendo a su disposición transporte y hospedaje en cuartos de hoteles o en Los Pinos así como alimentación. En México nos tocó la pandemia 2020 en un año de transición de un nuevo gobierno democrático elegido en junio de 2018 y que tomó posesión en diciembre de 2019, en la cual, el personal de salud cobre un papel el más relevante. Atiende a los enfermos de Covid-19 presentando, desde nuestro punto de vista, un sufrimiento emocional incalculable. Además del alto estrés laboral exigidos por la emergencia más allá de sus fuerzas para realizar sus propias tareas dentro del hospital, el dolor de verse contagiados o sus compañeros o el duelo que se pospone cuando colegas mueren por contagio, el agobio de extremar precauciones y la necesidad de estar hiper atentos para realizar adecuadamente los procedimientos de protección y prevención contra el contagio. Descuidarse es un peligro latente para a su vez ,no contagiar a su familia con la que viven. Es importante señalar que cuando se agrede a un solo integrante de la salud o muere por contagio, el dolor termina siendo para todo el gremio. El personal de salud ha reaccionado a través de su jefa solicitando en las conferencias de salud y hasta con lágrimas respeto, que les permitan trabajar con tranquilidad, hacer lo que saben hacer. La tristeza y el coraje que sienten tienen que ser reprimidos manifestándose en molestias físicas y síntomas psicopatológicos ya que no pueden responder con violencia ni expresar sus emociones, se saben indispensables y cruciales en este momento en el desempeño de sus funciones a favor de la vida. Históricamente el personal de enfermería, ha luchado desde el siglo pasado para que se les considere como profesional calificado para dar cuidados de calidad. Tienen arriba de ellas una jerarquía médica de carácter autoritario predominantemente, aunque sean licenciadas en enfermería, algunas con estudios de postgrado. Son responsables de los enfermos y su privacidad, el contacto con la familia, el principal enlace entre esta familia y el paciente. En muchas ocasiones guían y son el soporte y respaldo de médicos internos, residentes y personal de base, no son meras ayudantes dependientes de ellos para realizar sus procedimientos, suelen ser proactivas y tener iniciativas y recibir la alta demanda emocional de los familiares. En general, son sensibles y desarrollan mecanismos de defensa ante el dolor físico y emocional, reducen y o tratan de evitar el sufrimiento humano, ayudan a prolongar la vida, controlan riesgos, también su objetivo es curar enfermedades, así como rehabilitar, recuperar y promover la salud. Suelen ser receptivas y sensibles ante la ansiedad, depresión e incertidumbre y mucho más ahora con el paciente Covid 19 hospitalizado, grave e intubado. Como la investigación ha revelado, las cuidadoras (mayoritariamente mujeres) de personas enfermas, con discapacidad o vejez, están expuestas a lo imprevisto, a la muerte y por supuesto al burnout o desgaste profesional y es natural e inevitable que vayan desarrollando mecanismos de defensa que les lleva a reaccionar muchas veces con distancia, frialdad o indiferencia. Cada vez que una persona muere, el personal de enfermería se enfrenta de manera inconsciente con su propia muerte y vulnerabilidad, sus emociones oscilan entre su servicio ´el deber de la vida y la conciencia de morir´. Su rol es parecido al de una madre. Pero permitámonos conocer según nuestra experiencia tratando en psicoterapia a enfermeras y médicas, cómo es un día hábil en la presente emergencia y así comprender la mística y vocación de estas profesionales de la salud, su parte humana. Durante el día laboral en sus ocho horas de trabajo-que se convierten en más horas dado que se ayudan entre sí- no comen, no duermen, no toman agua y no van al baño y no lo hacen porque tienen que vestirse, con tres o cuatro capas de ropa esterilizada con la que se están protegiendo y prefieren no moverse, ni quitarse los gogles, caretas o guantes, ya que tardarían mucho más de lo que se tardan habitualmente. No quieren desperdiciar material que tiene que irse a la basura especial o volver a ser después esterilizado. Tampoco se sientan porque las condiciones de atención a un enfermo pueden cambiar súbitamente. Se quejan de problemas varios, como de várices, o inflamación cuando diariamente tienen que estar haciendo otros procedimientos, dentro del hospital, de preparar cadáveres para que se los lleven, ayudar a la identificación, etc. Además, enfrentan pacientes que se ponen nerviosos porque no ellos dicen no saber si hablan con un hombre o una mujer, no se ve la cara ni las expresiones faciales, razón por la cual decidieron portar un gafete con fotografía y su nombre. Lo que más les preocupa y da miedo es la intubación endotraqueal, porque se abren las vías respiratorias y se exponen directamente frente al virus. Comentan que también platican con sus pacientes sobre su vida, sus preocupaciones y ofrecen contención de manera intuitiva a las emociones derivadas del aislamiento y de la separación brusca de su familia, por si fuera poco, y con las energías que les quedan sirven de enlace entre pacientes y familia a través del celular. Todo lo anterior les trae consecuencias que es necesario conocer para brindarles el reconocimiento que merecen por este sacrificio único y especial que les toca inevitablemente. Las mascarillas ejercen presión sobre el cuello, les jala hacia delante y las encorva, la presión sobre los músculos de la cara les deja marca y a algunas pieles les hace heridas, los lentes además de empañarse lesionan la piel, las batas protectoras los mantiene permanentemente húmedos por el calor del cuerpo y el sudor, los dedos de tan húmedos que quedan se les forman pequeñas heridas. También con los hombres está sucediendo esto. Como consecuencia de lo anterior, algunos miembros del equipo de salud desarrollan dermatosis, se deshidratan, están presentando problemas renales, es decir la están pasando muy mal lo que tiene incluso consecuencias psicológicas, experimentan signos de depresión, ideas de muerte, agotamiento, desesperación, ataques de pánico y requieren contención y apoyo psicoterapéutico. Como profesionales de la salud mental recomendamos la necesidad de darles apoyo y contención emocional por el estrés laboral y toda la carga psicológica que cotidianamente enfrentan durante esta situación de crisis, para evitar que pierdan la confianza, la seguridad y la esperanza. El tema requiere realizar la investigación conducente para comprender y prevenir fenómenos sociales como este.





